









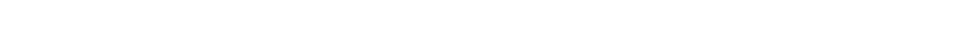
Borgata un tempo agricola, oggi stipata di case e casette circondate dal giardino, Codisotto sorge a pochi chilometri dalla torre di Luzzara, quella che figura spesso nei dipinti del Museo dei Naïfs.
Una di queste case, forse la più antica, in parte rifatta e in parte ampliata, pareti bianche e tetto sporgente, contiene un piccolo mondo: la famiglia e il lavoro di Azeglio Bertoni, scultore e pittore, uomo di modi civilissimi, per anni insegnante di disegno e storia dell’arte al liceo scientifico di Mantova.
Alto, magro, agile, con un pizzo quasi bianco e l’occhio scuro sempre all’erta, amico di Zavattini per lunghi anni, lo scultore ci accompagna alla sua casa. Sulla porta una campanella di bronzo come nei conventi avverte che qualcuno è in arrivo. Ma l’interno non è conventuale.
Il pianterreno è tutto occupato dallo studio: casse, mensole, attrezzi, creta, stracci umidi, e dovunque ti senti addosso gli occhi di personaggi grandi e piccoli, viventi fantasmi in corso di definizione. Sul banco, domina il medaglione per Zavattini, reso di profilo come nelle monete, ma di grande diametro ancora fresco, tanto che si distinguono chiaramente i segni dei polpastrelli oltre a quelli della spatola. È il bozzetto per la medaglia che poi verrà fusa in bronzo, a ricordare il trentennio della fondazione del Museo di Arti Naïves.
Di fianco all’ingresso sono lasciati alla rinfusa biciclette e motorini, caschi e giochi. Tutto il resto rispecchia un grande ordine, non una traccia di polvere o di terra. Dallo studio si sale al primo piano dove la famiglia vive. Pareti anche qui spesse e robuste e travi in legno scuro, nella parte che doveva essere stata la più antica, il granaio del nonno dove Azeglio sostiene di essere nato, oggi trasformato in luogo di soggiorno e nella cucina (là quasi sempre si cimenta lui, con pazienza e cura da gastronomo).
La cucina fa riscontro un bel camino di pietra che reca lo stemma della famiglia Brettoni (un nome modificato poi in Bertoni), e infatti un berrettone o cappello nero sovrasta le insegne a colori nei due campi.
Molti dipinti tappezzano le pareti, tra una profusione di oggetti e di fiori. Sono il frutto del primo periodo di Azeglio, quando si levava all’alba per andare a Parma, a studiare all’istituto d’arte con Renato Vernizzi, Armando Pizzinato, Umberto Lilloni, e il primo gli era il più congeniale. Altri tempi. Però gli rimase dentro un gusto preferenziale per la pittura emotiva postimpressionista, confermato poi dall’esperienza parigina una volta conseguito il diploma (per non parlare di altri viaggi attraverso l’Europa).
A un certo punto ebbe la folgorazione della scultura. Forse perché aveva incontrato le opere di Medardo Rosso con quel modellato a piccoli tocchi che esaltano la luce, quella disposizione quasi esclusivamente frontale, così vicina alle dimensioni del dipingere. La creta, il gesso, la cera gli permisero di compiere esperienze nuove e intense, arrivando per la prima volta alle tre dimensioni. Poco dopo sarà Giacomo Manzù a insegnargli una libertà più completa, allenandolo alla figura a tutto tondo, alle diverse posture e a infondere la malinconia anche nelle figure di nudo.
Se ci guardiamo intorno, nelle stanze abitate dalla famiglia, qua e là, tra i libri, sugli scaffali, sui tavoli, sulle mensole incontriamo tanti altri piccoli “abitanti”, modellati con tenerezza, sia quando si tratta ovviamente di bambini sia di ragazze dai lunghi capelli, della moglie Ennia dagli occhi turchini sia di vecchi amici.
Perfino l’indimenticato Zavattini è ripreso non senza ironia sulla sua traballante bicicletta: altezza, dieci o dodici centimetri, un piccolo capolavoro nella sua verità padana e universale.
Più spesso però ricorre una signora non più giovane, sempre la stessa, un volto, un busto, una figura seduta. È la madre, il tema che Azeglio continuamente studia nei diversi momenti della giornata, leggendo sull’amato volto i segni del tempo che scrivono la storia, riconoscendoli con il rispetto che impone l’amore ma anche con l’accanimento dell’artista. Lo stesso amore muove la sua mano quando modella una testina infantile o quella di amici, perché è proprio il sentimento, nelle sue diverse accezioni, che ne guida il lavoro. Questo è il suo mondo. Posano per lui la moglie, i figli, i genitori, un itinerario senza fine nel tessuto degli affetti. L’ultimo lavoro, in bronzo, dal titolo “Settembre”, raffigura il volto del figlio chiuso entro una estrosa cornice di tralci di vite; tutto il modellato rispecchia la ricerca di tensione, concentrazione, espressività, valori tattili. Ma il percorso artistico lo guida anche verso l’arte sacra, presepi, maternità, crocifissioni; con il medesimo sentimento di compassione verso la vita e verso la morte.
Agile, silenzioso, sempre attivo, Azeglio vive al centro di quel mondo che dal luogo del lavoro vero e proprio conduce su su, un piano dopo l’altro, dove il paesaggio muta completamente. Egli rimane pur sempre il perno, il nume tutelare di una famiglia complessa, formata anche dalla madre e dai suoceri che vivono dietro la facciata, ognuno chiuso nella propria solitudine. Dietro la facciata, ripeto, sta il dolore, sta la vecchiaia con le sue devastazioni e il suo pudore.
Casa Bertoni rispecchia dunque un’infinità di aspetti, palesi e segreti, che esalano soprattutto dalle opere finite e dai ritratti spesso sbozzati alla brava in tempi brevissimi, con esiti sorprendenti di interpretazione psicologica.
Uomo dai gesti calmi e calcolati, Bertoni tutto questo compie, senza sentirsi in ansia o far diventare ansiosi gli altri.
L’amore è diventato un’arte adulta.
LIANA BORTOLON

